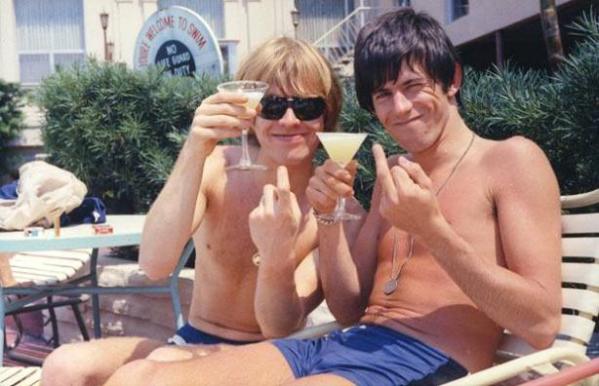Perchè non lo facciamo per la strada? Blue Bottazzi
Questo è un libro che mi è piaciuto tanticchio, ma parecchio, quindi la prendo larga.
Una delle cose più figherrime sull’Enterprise (Next Generation, Picard, non Kirk) è il Ponte Ologrammi, che è se vogliamo la pro-pro-pro-pro-bis nipote dell’Xbox. Entri in un gioco di simulazione, con tutte le sue cosine (acqua aria terra fuoco storia cibo vestiti personaggi) a posto e a modino, e vivi in questa realtà virtuale per il tempo che ti pare, facendo quel che ti va. Siccome Star Trek è una serie seria (ah ah), e soprattutto è stato girato quando le consolle di videogiochi quasi non c’erano, il ponte ologrammi non viene usato per i moderni giochi sparatutto, ma in genere per scopi didattici e scientifici. Il lato ludico della cosa è che puoi ricreare qualsiasi epoca del passato, e allignarci per un po’. Picard per esempio, vecchio mattacchione, rivive le battaglie napoleoniche di un suo avo ammiraglio. A volte ci sono casini, per esempio in un episodio stanno piazzati belli tranquilli nelle avventure di Sherlock Holmes e l’ologramma di Moriarty prende vita impadronendosi della nave, oppure in un’altra puntata, fighissima, i protagonisti sono intrappolati in una detective story hard boiled in omaggio a Dashiell Hammett, e vestiti come Bogart e la Bacall vagano bevendo cocktails entrando e uscendo da fumosi night-club.
Il ponte ologrammi dell’Enterprise è una figata. E’ la madre di tutte le passaporte, è quasi un TARDIS: è una macchina del tempo.
Io, per me, non ho mai avuto dubbi su cos’avrei caricato sul ponte ologrammi, dal primo minuto in cui ho capito cosa fosse: il concerto di Bruce a Nassau dell’80, seguito a stretto giro dal tour del 78. Ma prima, il The River tour. Comunque, dopo aver caricato nel programma dell’Holodeck una settantina di concerti suoi di quell’epoca lì, e andando avanti e indietro nel tempo dal 73 all’88, ma perchè no, giassò cosa ci sarebbe per me: giornate e giornate in America negli anni 70, a comprare dischi rock’n’roll e a presenziare concerti di tutti quelli che mi sono persa per evidenti limiti generazionali. Già solo il pensiero di tutte le possibilità che mi si aprirebbero mi fa girare la testa: penso che se davvero esiste un paradiso, sia proprio così. Con tre quattro librerie nelle vicinanze, ovvio.
Bene. Il ponte ologrammi dell’Enterprise non esiste, ahimè. E, come dice il Re, Life sucks, and then you die. E’ tutto davvero così brutto? No. C’è un altro modo di rivivere i sogni rockenrolli, ed è quello di prendere in mano un libro come questo.
Blue Bottazzi è una generazione indietro la mia, è un fortunello che ha potuto esplorare quegli strani, nuovi mondi musicali dieci, quindici anni prima di me, anche se non è che mi lamento perchè comunque chi è arrivato dopo di me sta pure peggio, per dire: sempre consolarsi guardando chi è più sfigato di te, è il sale della vita.
E’ un giornalista musicale che pur vivendo come dice lui nella periferia dell’impero (rockenrollo) ha cominciato ad ascoltare musica rock, a comprarla e a viverla nei primi anni 70, e non ha più smesso. E perchè avrebbe dovuto, trallaltro?
Perchè non lo facciamo per la strada? è un libro diviso in 31 capitoli, ognuno dei quali narra un qualche aspetto del mondo rockenrollo degli anni 60, 70 e 80: concerti, vinili, musicassette, 45 giri, canzoni, concetto di album, Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, punk, groupies, radio, album in studio, album doppi, album dal vivo. Ci sono storie, aneddoti, ricordi, racconti di quello che è stato un mondo in cui quelli della mia e della precedente generazione hanno vissuto per tutta la loro infanzia e giovinezza, un’epoca oramai mitologica in cui compravi veri dischi registrati da veri musicisti che suonavano veri strumenti dal vivo. Nella vera realtà trallaltro, mica su un ponte ologrammi.
Blue Bottazzi è stato un giornalista del Mucchio Selvaggio in anni in cui tutti noi ne aspettavamo l’uscita mensile per imparare a memoria i dischi recensiti e scegliere, con infinite sofferenze vista la scarsità della paghetta, a quali dedicare l’acquisto. Il Mucchio era una rivista che nella città dove io vivevo da adolescente metà delle rivendite di giornali non sapeva cosa fosse: quando andavo ad acquistarla se c’era la moglie dell’edicolante mi guardava a volte strana, forse pensando che fossi una qualche deviata che le chiedeva di rovistare tra le riviste sconce nel retro. Avevo con la pratica negli anni sviluppato un siparietto per cui arrivavo sciorinando un bravo sorriso da Stregatto Ciellino e chiedevo C’è PER FAVORE il mucchio selvaggio, LA RIVISTA MUSICALE? E se c’era, me ne uscivo per correre a casa e immergermi nelle storie di gruppi e cantanti, per guardare quelle foto che parlavano di incredibili sessioni musicali, per imparare massime di vita rockenrolla mai dimenticate: Se un disco ti piace al primo ascolto, non è un disco buono (ma non sempre).
Il Mucchio e i suoi giornalisti ti trasportavano ogni mese nel Nirvana, ti parlavano di cose che nessuno nella tua famiglia o tra i tuoi compagni di scuola capiva, ti facevano sentire di non essere solo a credere che il Rock non era canzonette, non era Massì metti su questa che è carina, non era Beh dai sentiamo la canzone italiana tanto l’ha copiata dall’inglese, è la stessa cosa. No cazzo, non è la stessa cosa. Il Mucchio Selvaggio era con te a credere che il rock era una roba seria, era una passione su cui costruire un’esistenza, perchè era una cultura. Era musica, ma anche libri, e film. Erano concerti, ed erano vinili. Era, sarebbe diventata, stava per diventare, la nostra vita.
Blue Bottazzi ripercorre tutto questo, e più indietro ancora: è stato un giovanotto negli anni Settanta, quando il rock viveva la sua età dell’oro. E tutto quello che era cultura rock ai tempi, lui l’ha vissuto: la radio, le prime riviste musicali, gli scambi di vinili e cassette, il negoziante-amico-pusher che te li forniva, i vinili. C’era quando le discoteche facevano ascoltare rock’n’roll, prima della musica disco. C’era quando in una qualsiasi annata di quel decennio potevi pescare un capolavoro, e senza sforzo. C’era per Exile on Main Street e Blood on the tracks, per Tubular Bells e Rock’n’roll Animal, e te lo racconta tutto questo, e anche un po’ di più.
Quando ho letto questo libro, sono tornata a pensare a quanto siano cambiate le cose da quegli anni. L’atto più evidente, ovvio, è la scomparsa di questa gravosa usanza di dover pagare per la propria musica. Io sono disoccupata e quando va bene precaria, non mi lamento certo del poter sentire tutta la musica nuova che voglio quando voglio. Capisco anche bene le risate che si fanno i giovani quando provi a spiegare il concetto di rimborsare un artista per una cosa che ha creato di cui tu usufruisci. E poi è anche vero che quasi tutti gli artisti che io amo sono rocker già miliardari da un pezzo, e tutto quello per cui potevo pagare l’ho già dato, senza dimenticare che l’ho spesso dato doppio, nel passaggio dal vinile al cd quando mi sono dovuta ricomprare metà degli album che avevo. Rimane che questo fatto di andare nei negozietti e sfruculiare tra i dischi anche per un’ora, tirar fuori uno e poi due e poi tre dischi di cui avevi sentito parlare da tempo, comprarne uno e la tua amica comprava l’altro e poi vi scambiavate le cassettine e poi appena avevi i soldi te lo compravi (perchè le cassettine erano esplorazione, scambio, test, non pirateria), questo è un mondo che mi spiace di avere perso. Non penso che un artista diventi meno creativo se non è pagato, figuriamoci: certamente chi lo sponsorizza ha però molta più voce in capitolo, se i soldi che entrano ora sono un terzo del passato. E questo incide.
Rimane, come dice Blue, che c’è stato un mondo in cui comprare un disco era comprare un’opera d’arte, dalla copertina alle fotografie ai testi alla musica; e te la sceglievi, e te la portavi a casa, e te lo ascoltavi tutto, perchè un album era creato con un senso, dalla prima canzone del lato A che spaccava alla prima del B che era più una ballata, tutto tutto fino in fondo, perchè era pensato per essere così. E poi ti rialzavi, tornavi allo stereo, e ricominciavi. Questo, alla fine, era amore per la musica.
Ma questo è adesso, e allora era allora.
C’è il capitolo sul cinema e quello su John Belushi, uno sulle canzoni d’amore e uno sul sesso, Mink de Ville e le Donne del rock, uno sulle etichette e uno sulle copertine dei vinili. In più, alla fine di ogni capitolo c’è un decalogo, se vogliamo una serie di canzoni da cassetta, di canzoni relative a quel periodo: 10 must have, 10 dischi soul, 10 film, 10 grandi B sides, e così via.
C’è il capitolo sulle C90, ed è così perfetto che mi sembra di essere ancora lì in cameretta a prepararne una, a tirare fuori il pennarello nero per fare i bordi ritagliando fotocopie miniaturizzate delle copertine degli album da incollare sul lato largo, mentre Bobby ne decora un’altra con l’Uniposca per fare il logo dei Cramps.
Non è mica un libro perfetto, per carità: la copertina non mi piace, il Blue ogni tanto spocchia (ma fa bene, anch’io lo farei al suo posto), a volte alcuni pezzi sono slegati, e forse chi legge tantissimi libri di musica molte cose già le saprà. Ma non si viaggia solo per vedere cose nuove, si viaggia per pensare, per liberare la mente, per ricordare: e Perchè non lo facciamo per la strada? ti porta in viaggio ai confini di un impero caduto nei primi anni Novanta, ed è perfetto.
E’ un libro per chi c’era, e anche per chi non c’era e avrebbe voluto esserci: è un viaggio nel tempo. E’ anche per chi non c’era e non avrebbe voluto esserci: perchè se no mentre ve la tirate un po’ acidelli scrollando una delle vostre playlists di brani top tracks non vi verrà mai il dubbio che trent’anni fa ma anche venti c’era gente che alle vostre compilation così indie e così condivisibili nella vostra rete avrebbe proprio pisciato in testa, o per lo meno ruttato in fazza, via. Se non siete cresciuti con la scritta sul Mucchio: Guida Spirituale= John Belushi, ve la meritate la piscia in testa sui brani trendy.
Quindi, potete star lì a diventare menarelli sul perchè non abbiate un ponte ologrammi e come sia ingiusto tutto ciò. Oppure potete comprarvi Perchè non lo facciamo per la strada? e viaggiare viaggi rockenrolli. Oh io ve lo dico, eh, poi vedete voi.
Di recente un ragazzo mi ha chiesto “I Beatles sono stati davvero una gran band? Perchè non mi pare” – Sì, furono i più grandi. Su quale disco? Tutti.
Blue Bottazzi.